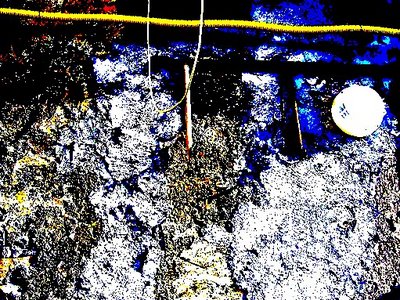venerdì, 24 ottobre 2003 [link]
Apologia dell’asimmetria (en prose)
Uno dei libri più interessanti pubblicati da Donzelli è Il mondo non finisce, di Charles Simic. Il titolo ha in inglese un ulteriore segmento testuale che dice «prose poems». E si tratta – certo – di brevi poémes en prose, ma da non immaginare catturati da una facile o ‘cantabile’ (né troppo facilmente citabile) lirica.
Anzi. I testi di Simic registrano molte caratteristiche (starei per dire slave, generalizzando, immaginando legami per esempio con Holan, o con Zbigniew Herbert) specifiche della narrazione interdetta, asimmetrica, anche sognante o giocosa, ma nella quale non si dà, o si dà in forma problematica, la sfera del microracconto, del testo ritmicamente e narrativamente lineare.
Piuttosto, interviene una vera frammentazione e riconfigurazione – surreale – di coerenze narrative separate. Come se ogni prosa rappresentasse la somma miracolosa e senza resti di schegge di eventi eterogenei; o minuscoli apologhi emergessero solo per revocare il proprio senso e forma, tessendone semmai di incomprensibili quanto necessari:
«Storie di fantasmi come equazioni algebriche. La piccola Emily alla lavagna è spaventatissima. Le X sembrano un cimitero di notte. La maestra vuole che frughi tra di esse con il gesso. Tutti i bambini trattengono il respiro. Il gesso bianco stride una volta tra i più e i meno, poi torna il silenzio»
(p.35; altro riferimento possibile – lo vediamo – è la prosa di Julio Cortàzar).
L’elemento surreale, come in una galleria di piccoli quadri-enigmi, è la sigla di Simic e di altri poeti contemporanei americani: Mark Strand e John Ashbery innanzitutto. Lo osserva il curatore e traduttore della raccolta, Damiano Abeni, che giustamente fa riferimento per Simic (nato a Belgrado nel 1938 anche se prestissimo trasferitosi negli USA) alla «tradizione balcanica ed est-europea».
Un’ulteriore qualità di Simic è l’ironia sul grandioso. Pensiamo a un incipit come «It was the epoch of the masters of levitation» («era l’epoca dei virtuosi della levitazione»), beffa riuscita ai vezzi kitsch dei titoli d’enciclopedia o di serial tv. È, allo stesso tempo, incipit levitante, gioco di ironia appunto: centrato sulla leggerezza/debolezza non solo del reale tradotto in comunicazione mondiale («Avevamo paura di parlare, di respirare» – si legge più avanti), ma della stessa struttura d’immagine del testo, che non a caso si conclude con una netta visione d’aria: «vedemmo […] le camicie sollevare le maniche vuote sul filo del bucato della cieca».
E notiamo: viene qui tessuto anche un ennesimo correlativo oggettivo: ma daccapo misterioso, indecifrabile, irrelato e dunque capace di radicalizzare il discorso che le prose ininterrottamente rivolgono al mondo, avvertito come ostilmente-sottilmente impenetrabile. Un mondo che – suggerisce ancora Abeni – tuttavia non finisce. Anche nel senso che non si compie mai, così nella percezione come nella trascrizione o interrogazione alfabetica che ne tentiamo.
Charles Simic, Il mondo non finisce, traduzione e cura di D.Abeni, Donzelli Editore, Roma, 2001. (Titolo originale The world doesn’t end: prose poems, Harcourt Brace & Company, San Diego, 1989).
Recensione riproposta (già pubblicata su «Il Grandevetro», a.XXV, n.159, ott-nov.-dic. 2001, p.43); e ora in parte anche in IBS.
venerdì, 17 ottobre 2003 [link]
Perf.
La frequenza a volte notevolissima con cui nelle strutture ricettive e distributive della poesia contemporanea compaiono il corpo, la performance, e tutti i macro ed epifenomeni che partono dallo slam-poetry e arrivano al teatro-teatro, alla canzone d’autore, al film-da-romanzo, ha un volto doppio.
Da una parte è il risultato e la somma positiva di codici di trent’anni e più di sperimentazione. Che ‘portano’ una quantità di messaggi. Molti di essi politicamente ben funzionanti. Fattori e vettori di resistenza. Pensiamo alla satira, all’intensità di scritture del corpo ‘storiche’ (Pasolini).
D’altra parte un forte rischio, in certi casi percettibile, è quello di circoscrivere appunto all’ossessione della presenza la validità – la durata – dei testi, delle opere.
Dove l’autore si assenta, non esiste opera. Può succedere. Questo mette in pericolo ciò che in pericolo è già (sempre per strade politiche, note): la storia. Individuale. Ossia una storia.
Morto un autore, l’alternativa posta è tra museificazione e oblio. In questi termini, precisamente il corpo vivente si spegne (il corpo che – vivo l’autore – era fittamente vincolato al senso). Doppia morte, così.
«Siamo un paese senza memoria»? Si può affermare. Nonostante a legioni sciamino filologi, restauratori, cameramen, enti storicizzanti, archivi e biblioteche di vetro – o vetroresina. Perché, semplicemente, anche la memoria è cosa viva. E allora forse va anche coltivata l’ossessione per il corpo. Ma:
Non è male leggere i testi degli autori. (Anche: in silenzio). (Dove questo esista). I testi parlano precisamente, sempre e comunque, in assenza di chi li ha emessi, e ne difendono o incrinano il valore. Ma sì: così un puro-solo attore non passerebbe alla storia, campito in stemmi.
Mentre non verrebbe dimenticato chi attore non era, ma scriveva bene.
[link]
Sociologismo volgare
Molte ragioni di assenza dai luoghi dove si fa poesia (letta) risiedono in un’ipotesi da verificare (e, da chi scrive, già ora verificata): non ha più spazio di esistenza quello che anche poco tempo fa era definibile poeta operaio. (Excusez, per la patina ‘vetero’).
Molti obietteranno che fitta/forte fatica comporta la vita di tutti, aujourd’hui. Contro-obiezione: la fatica fisica, unita a quella intellettuale, al contatto con il pubblico, all’assorbimento di tensioni altrui (ogni lavoratore dipendente sa di che si parla), per un tempo di oltre 8 ore al giorno (molto oltre le 8 ore), bloccano ogni attività. Bloccano le ‘partecipazioni’. Del resto, chi non ha altro che il lavoro per tenersi in piedi – non contando su nessuna altra ricchezza – deve dare precedenza alla partita doppia delle energie e del denaro. (Woolf versus Bataille). La classe sociale di appartenenza, lo si voglia o no, determina – non con forza ma proprio con violenza – una quantità di azioni e omissioni dell’auctor. A scrivere è sempre il corpo.
Traducendo: non me ne vogliate per le assenze. Forse è anche vero che la mia idea di letteratura contempla una presenza che è in primo luogo testuale. Ma molte idee (contemporanee, che solo in parte ‘sento’) della letteratura non guardano troppo di buon occhio il testo. O non vorrebbero ci fosse ‘solo’ quello.
Tuttavia: quando nessuno di noi esisterà più, resterà precisamente la carta, da sola, con le file delle parole. A difenderci (a diffonderci; diffondersi su quanto eravamo).
mercoledì, 08 ottobre 2003 [link]
Su L’esperienza, di M.Sannelli
Massimo Sannelli ha pubblicato recentemente, tra altri libri, L’esperienza. Poesia e didattica della poesia, Edito da La Finestra (Trento 2003).
Il libro presenta quattro qualità: 1, è un “report” su un’esperienza (intesa “come tema” e come periodo vissuto) di insegnamento/dialogo in una scuola; 2, è un testo di poetica; 3, raccoglie e anzi unisce e fonde brani di Sannelli, dei ragazzi della scuola, e di altri autori che hanno collaborato e contribuito con pagine proprie ad affrontare l’argomento; 4, è una micro-raccolta di poesie dell’autore.
Alla ricchezza argomentativa e bibliografica (un saggio che parla di altri saggi) unisce dunque una raggiera di interessanti – e diverse – linee e scritture di prosa e poesia. Ha il pregio dello spessore saggistico unito alla serietà/leggibilità del resoconto di un tratto biografico.